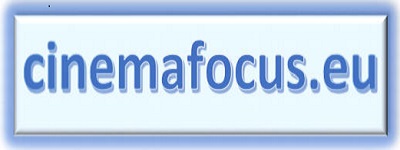
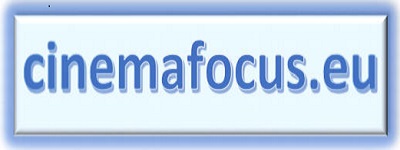
Le aspettative del pubblico: Come gli spettatori interagiscono con i film
Luciano Mariani
info@cinemafocus.eu
© 2025 by Luciano
Mariani, licensed under CC
BY-NC-SA 4.0
| Introduzione |
|
Psyco/Psycho (Alfred Hitchcock, USA 1960) |
6. Quando un film gioca con le aspettative: conferma vs sovversione
6.1. "Fair play" vs "barare"
Un'esperienza visiva, se considerata come un "contratto" tra un film e il suo pubblico, include per definizione il concetto di "fair play": un film deve rispettare i suoi spettatori e offrire loro un prodotto coerente e onesto che riconosca anche la loro intelligenza e sensibilità. Un romanzo poliziesco, ad esempio, deve fornire agli spettatori elementi sufficienti per consentire loro di formulare ipotesi ragionevoli e logiche sul suo esito: l'introduzione di nuovi elementi in conflitto con quelli precedenti è certamente consentita come parte del gioco della "verifica delle ipotesi" (che fa anche parte del godimento di un film del genere), ma dovrebbe essere coerente con quanto accaduto fino a quel momento, o almeno non mettere a repentaglio il senso generale di "credibilità" e "affidabilità" della narrazione. Se gli spettatori percepiscono che si è verificata una sovversione o una discontinuità, senza indizi sufficienti per giustificarla nel contesto della storia, potrebbero avere la sensazione che si sia verificata una violazione del "contratto": il senso di sorpresa legato all'introduzione di nuovi elementi, invece di essere un'esperienza piacevole e coinvolgente, trasforma le aspettative frustrate in quella che può essere percepita come una violazione del "fair play", ossia un modo di "barare". E ancora più importante è la "rivelazione finale" che chiude la narrazione: gli spettatori si aspettano un risultato coerente con quanto accaduto nel corso del film.
È quasi una regola, almeno nei romanzi polizieschi "classici", che sia il detective (come personaggio) sia il pubblico abbiano pari opportunità di seguire lo sviluppo dell'azione e di "risolvere il mistero", avendo accesso agli stessi indizi. Questa "regola", tuttavia, può essere giocata in vari modi dal film, la cui preoccupazione principale è quella di "manipolare" (per usare il termine impiegato da Spielberg nella citazione qui sopra) il suo pubblico in termini sottili ma efficaci, allo scopo di fornire il senso di sorpresa e suspense che ci si aspetta da questo genere cinematografico. Il termine "manipolazione" è forse carico di connotazioni negative, ma può anche essere interpretato come la distribuzione attentamente studiata degli indizi durante il film, con l'obiettivo fondamentale di garantire il godimento della storia.
I racconti horror, gialli, noir e polizieschi (così come altri generi cinematografici) hanno spesso fornito agli spettatori informazioni parziali o addirittura fuorvianti per aumentare il loro livello di suspense e invitarli a "unirsi al gioco". Gli esempi di "imbroglio" diretto non sono così frequenti e si potrebbe rimanere sorpresi nello scoprire che il maestro della suspense, Hitchcock, imbrogliò sicuramente il suo pubblico quando, all'inizio di Paura in palcoscenico (USA 1950), inserì un flashback che poi si rivelò falso. Un "trucco" simile è stato utilizzato in I soliti sospetti (Bryan Singer, USA 1995), inserendo un narratore inaffidabile e persino una falsa inquadratura "di punto di vista" che mostra un testimone in una scena finale, con il risultato di confondere il pubblico e lasciare loro più di un dubbio sul finale effettivo.
|
Paura in palcoscenico/Stage fright |
I soliti sospetti/The usual suspects |
Naturalmente, al pubblico in genere non piace essere "imbrogliato", ma potrebbe comunque trovare il risultato di tali film accettabile e persino divertente se la struttura complessiva della storia è abilmente realizzata (anche in termini di stile, e non solo di contenuto narrativo) e fornisce ragioni sufficienti per accettare quello che alla fine riesce ad essere un modo intelligente e coinvolgente per mantenere interessato il pubblico. Come accennato alla fine della sezione precedente, tutto ciò si riferisce anche alla disposizione del pubblico moderno ad accettare tipi di chiusura dei film che non forniscono finali chiari e lasciano loro un senso di "affare incompiuto".
6.2. Nuove narrazioni e nuovi pubblici
La crescente importanza delle serie sulle piattaforme
televisive e di streaming ha aggiunto nuovi significati al "contratto"
tra un film e il suo pubblico. Spesso le serie durano diverse stagioni, ciascuna
delle quali comprende diversi episodi, il che implica che le storie e i
personaggi possono subire molti più "colpi di scena" rispetto a un normale film
di 120 minuti. Ciò può creare problemi, ad esempio per quanto riguarda il
trattamento dei personaggi, che devono in qualche modo cambiare e svilupparsi
mantenendo alcuni o la maggior parte dei tratti di personalità stabiliti fin
dall'inizio. Le sfide che gli sviluppatori di serie devono affrontare sono rese
ancora più gravi dalla natura del loro pubblico, che spesso si trasforma in
comunità di fan particolarmente desiderose di percepire qualsiasi
discontinuità indebita o inefficiente nello sviluppo del personaggio. Queste
comunità di fan, la cui influenza è amplificata dalla loro massiccia presenza su
Internet attraverso blog, social network, siti web ecc.,
possono reagire in modi forti e inaspettati a quello che percepiscono come un
trattamento ingiusto nei confronti di personaggi affermati e amati, a volte al
punto da mettere a repentaglio l'intera serie, minacciando di ritirare la loro
fedeltà (e il loro abbonamento alle piattaforme di streaming). Gli
sviluppatori delle serie sono quindi costretti a tenere conto delle opinioni dei
fan, anche se ciò può significare apportare modifiche alle
sceneggiature originali. Tale è l'enorme potere del nuovo pubblico, che sembra
essere in grado di esprimere la propria opinione sull'adempimento del
"contratto" a livelli mai visti. La questione della credibilità della storia e
dei personaggi ha assunto una nuova forza e sovvertire le aspettative è
diventata una mossa ancora più pericolosa.
Studio di caso: C'è ancora domani
(Paola Cortellesi, Italia 2023)
|
Trailer |
La vita quotidiana vista dal punto di vista di Delia |
|
|
|
| Riassunto della
trama |
Aspettative |
| A Roma,
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, le persone vivono in
povertà. Una donna, Delia, è la moglie del violento Ivano e madre di tre
figli, tra cui l'adolescente Marcella. Tra un impegno domestico e
l'altro si prende cura del suocero Ottorino e si occupa di cucito e
riparazioni per vari negozi cittadini, oltre che di lavanderia per i
ricchi. Si sforza di risparmiare un po' di soldi per comprare l'abito da
sposa di Marcella. |
Ci viene mostrata la condizione
delle donne come vittime di un violento sistema patriarcale, che sembra
non lasciare loro alcuna speranza per un futuro migliore. Tuttavia, ci
viene anche mostrata la resilienza di Delia e ci aspettiamo di vedere di
cosa è capace. |
| Vediamo Delia incontrare Nino, un meccanico di cui era innamorata e che
sta progettando di trasferirsi nel Nord Italia in cerca di un lavoro
migliore. Nino la ama ancora e la implora di lasciare Roma con lui nei
prossimi giorni, ma Delia sa che sarebbe impossibile lasciare suo marito
e i suoi figli. |
Ci chiediamo se questa storia
d'amore non possa mai avere un "lieto fine". |
| Quando Delia riceve una lettera indirizzata a lei, rimane perplessa,
poiché tutta la posta è sempre indirizzata a suo marito. Apre la
lettera, rimane scioccata e turbata dal suo contenuto e la nasconde in
una scatola. |
Poiché l'unico "segreto" nella vita di Delia sembra essere la sua
relazione con Nino, quando vediamo Delia nascondere la lettera, tendiamo
a pensare che si tratti di un suo messaggio. |
| Pochi giorni dopo, incontra di nuovo Nino e ancora una volta capisce che
devono separarsi per sempre. Chiede però poi alla sua amica Marisa di
aiutarla, fingendo che staranno insieme la domenica pomeriggio
successiva. Marisa è d'accordo, ma avverte Delia: "Se lasci Ivano,
assicurati che non ti trovi ... se no, ti ucciderà". |
Marisa non ha dubbi sul piano di Delia, che però Delia non conferma. Tendiamo ad aspettarci ciò che Marisa si aspetta. |
| Sabato sera Delia mette una nuova camicetta e la misteriosa lettera
nella borsa... Nel frattempo vediamo Nino fare le valigie, pronto a
lasciare Roma... Domenica mattina, la morte improvvisa del suocero complica le cose poiché la casa si riempie di parenti e amici. Tuttavia, Delia dice alla sua amica Marisa: "C'è ancora domani". Poi lascia una busta con tutti i soldi accanto al letto di sua figlia. |
I preparativi di Delia, e la scena di Nino che fa i bagagli, sembrano confermare le nostre aspettative. |
| Lunedì mattina presto, Delia trova una scusa per uscire di casa, ma,
mentre esce, lascia cadere inavvertitamente la lettera sul pavimento.
Corre per le strade, passa davanti al garage di Nino e la vediamo
mettersi la sua nuova camicetta e il rossetto. |
Ancora una volta, tutte le azioni di Delia sembrano confermare la nostra
ipotesi secondo cui sta effettivamente lasciando la casa. |
| Nel frattempo Ivano trova la lettera e, furioso, la butta per terra e
corre dietro alla moglie. Quando Marcella si alza, trova la busta con i
soldi. Raccoglie la lettera dal pavimento... |
Tendiamo a interpretare la reazione di Ivano nello stesso senso ... |
| Poi vediamo Delia in mezzo a una folla di donne, in attesa davanti a un
edificio. Ci rendiamo conto che questo è il 3 giugno 1946, il fine
settimana in cui agli italiani fu chiesto di votare e scegliere tra
monarchia e repubblica (oltre alla prima volta che alle donne fu
concesso il diritto di voto). All'improvviso, Delia rimane scioccata
nello scoprire di aver perso la "lettera" (cioè la tessera elettorale),
e Ivano ora la sta raggiungendo... ma Marcella riesce a dare la tessera
a Delia, così che ora può votare e condividere questo giorno glorioso
con tutte le altre donne ... |
... finché non scopriamo cos'è veramente la "lettera" e qual è la posta
in gioco: Delia festeggia il suo primo giorno di "libertà" con tutte le
donne mentre l'Italia entra in una nuova era... |
| Il film gioca chiaramente con le
aspettative dei suoi spettatori secondo cui la misteriosa lettera, che
appare dopo l'incontro tra Delia e Nino, sembra avere a che fare con la
loro relazione, forse un invito a lasciare la città insieme ... Tutti
gli eventi successivi sembrano confermare questa ipotesi, anche se il
"piano di fuga" è una deduzione da parte di Marisa (amica di Delia), che
Delia non conferma. E siamo portati a mantenere le nostre
aspettative poiché molti dettagli del comportamento di Delia sembrano
andare in questa direzione. Quindi la rivelazione finale giunge come una
sorpresa, aggiungendo anche un nuovo significato e un nuovo valore
all'esperienza di Delia: il voto delle donne in questo importante
referendum ha il potere di indicare un futuro diverso dal cupo presente.
Naturalmente, se ci avessero detto qual era effettivamente la "lettera",
o se avessimo saputo che il giorno esatto dell'anno era la data cruciale
del referendum, le nostre aspettative sarebbero state molto diverse ...
La sovversione finale delle aspettative accresce il valore morale del
film e ne trasmette il messaggio in modo molto più potente. |
|
7. Due momenti cruciali nell'esperienza della visione: le sequenze iniziali e finali
7.1. Le sequenze di apertura
"La natura sequenziale della narrazione rende le parti iniziali di un testo cruciali per stabilire ipotesi. Un personaggio inizialmente descritto come virtuoso tenderà ad essere considerato tale anche di fronte ad alcune prove contrarie; le ipotesi iniziali saranno qualificate ma non demolite a meno che non vengano presentate prove molto forti." (Nota 4)
Le sequenze iniziali di un film rivestono un'importanza particolare poiché introducono gli spettatori al mondo del film, creando così l'insieme iniziale di aspettative che li guideranno per il resto del film. Come affermato nella citazione, queste aspettative sono particolarmente forti e rimarranno la principale fonte di creazione di significato a meno che non vengano prodotte ulteriori e forti prove per cambiarle e aggiornarle.
L'importanza di questo "incontro" iniziale con un film può essere difficilmente sottovalutata. La sequenza di apertura è quella in cui il pubblico e il film iniziano a interagire, dove la domanda (il pubblico) incontra l'offerta (il film), dove ci fermiamo per un momento sulla soglia di una nuova esperienza. È un momento di transizione, un passaggio in un mondo diverso, un ponte tra la realtà "reale" della nostra vita quotidiana e la realtà "immaginaria" del film. All'inizio di questo studio abbiamo identificato il rapporto film-pubblico come una sorta di "contratto" e un contratto, per definizione, implica una condivisione di informazioni, bisogni, motivazioni e atteggiamenti; in altre parole, l'esistenza di un terreno comune condiviso da produttori e consumatori.
Se i cineasti pensano o temono che il loro pubblico (o parti considerevoli di esso) possa non condividere questo "terreno comune", devono fornire informazioni esplicite o presumere che gli spettatori saranno in grado di scoprire da soli gli elementi mancanti attraverso inferenze o implicazioni. Forse non abbiamo ancora visto un certo personaggio, ma attraverso i dialoghi e altre informazioni non verbali possiamo giustamente supporre che tale personaggio esista e abbia determinate caratteristiche positive o negative. Potremmo vedere un gruppo di spensierati adolescenti iniziare un viaggio attraverso una foresta, ma i segnali audiovisivi trasmessi dal film potrebbero farci presumere che questo non sarà un piacevole picnic in campagna, ma piuttosto l'inizio di un'esperienza orribile. In un certo senso, quindi, cineasti e consumatori interagiscono sempre attraverso il testo filmico: i primi forniranno abbastanza (ma non troppe!) informazioni affinché i secondi possano seguire la storia, e gli spettatori inevitabilmente si porranno delle domande ogni volta che sullo schermo appare qualche informazione nuova e inaspettata. Porre e rispondere a domande, come in una normale conversazione, e collaborare per far "fluire" la conversazione, sono quindi una caratteristica del rapporto produttore/consumatore cinematografico. Possiamo così apprezzare appieno il ruolo e l'importanza delle sequenze di apertura: spesso (anche se non sempre) stabiliscono il contesto, la situazione, i personaggi, attivando le informazioni che gli spettatori già possiedono (ad esempio un contesto del Far West, i personaggi tipici di una scuola superiore, le tensioni in un carcere) e, allo stesso tempo, fornendo agli spettatori la quantità iniziale di nuove informazioni, abbastanza da indurli a porsi domande sulla storia che sta per svolgersi davanti ai loro occhi e alle loro orecchie, creando in una parola il "terreno comune" che consentirà loro di seguire (e dare un significato a) le sequenze successive.
Anche se, in generale, si potrebbe dire che una sequenza di apertura è progettata per "agganciare" gli spettatori e stimolare il loro interesse e le loro emozioni fin dall'inizio, i film lo fanno in modi molto diversi, e certamente non nella stessa misura. Questo è ciò che ci consente di identificare diverse funzioni che le sequenze di apertura possono svolgere, tenendo presente che una sequenza iniziale può svolgere più di una di queste funzioni. Le aspettative possono quindi essere stabilite, ad esempio:
- fornendo un prologo, o un evento (o una serie di eventi) che metta in moto la narrazione:
A Venezia ... un dicembre rosso shocking/Don't look now (Nicolas Roeg, GB/Italia 1973)
Le inquadrature di una ragazza che indossa un impermeabile rosso e gioca in un giardino (sullo sfondo è raffigurata la riconoscibile architettura di una casa di campagna inglese) si alternano alle inquadrature dei loro genitori, John e Laura, all'interno della casa. John sta guardando delle diapositive, ma all'improvviso ha una sorta di premonizione e si affretta ad uscire ... e mentre strisce di sangue iniziano a diffondersi su alcune delle diapositive che stava guardando (in particolare una chiesa), scopre che la figlia Christine è annegata. Questo è il tragico evento che mette in moto la storia: seguiremo la coppia a Venezia, dove John ha accettato l'incarico da un vescovo di restaurare un'antica chiesa. Alcuni dettagli mostrati nella sequenza iniziale (come l'impermeabile rosso della ragazza, le diapositive della chiesa e il sangue) saranno cruciali per la narrazione che seguirà, ambientata a Venezia.
- stabilendo il luogo e il tempo del mondo di un film, cioè l'ambientazione spaziale e temporale in cui si svolgerà l'azione:
Frenzy (Alfred Hitchcock, GB 1972)
Il film inizia con una folla che assiste a un discorso del sindaco di Londra sulle rive del Tamigi (con il Parlamento e il Big Ben chiaramente visibili). L'attenzione della gente, tuttavia, si sposta rapidamente su ciò che sta realmente accadendo sotto di loro: la polizia sta trascinando a riva il corpo di una ragazza, che porta una cravatta attorno al collo - e alcuni nella folla commentano che si tratta di un altro omicidio da parte dell'"assassino della cravatta".
- introducendo i personaggi del film:
La maledizione della prima luna/Pirates of the Caribbean - The curse of the Black Pearl (Gore Verbinski, USA 2003)
Ambientata tra mare e cielo, con l'ausilio di un'adeguata colonna sonora, ci viene mostrata la prima immagine del capitano-pirata John Sparrow (Johnny Depp) a bordo di una piccola nave. Tutte le immagini di queste sequenze iniziali servono a presentare l'eroe della storia, evidenziandone l'imponente figura con inquadrature medie e primi piani, nonché la sua abilità, la sua forza fisica e il suo bell'aspetto...
- trasmettendo il tema principale di un film:
Full metal jacket (Stanley Kubrick, USA 1987)
La sequenza iniziale è composta da una serie di inquadrature di ragazzi rasati a zero, la cui folta capigliatura cade sotto il rasoio... La maggior parte degli spettatori riconoscerà immediatamente questo come parte di un addestramento militare molto precoce (e le sequenze seguenti mostreranno effettivamente queste giovani reclute del corpo dei marines in un campo di addestramento prima di essere inviate a combattere nella guerra del Vietnam). La sequenza iniziale cattura così il tema del film, che non riguarda solo la guerra, ma anche come l'addestramento alla guerra implichi la cancellazione di ogni traccia del carattere individuale e la trasformazione dei ragazzi in efficienti "macchine assassine". Come spesso accade nei film di Kubrick, la musica di sottofondo, in questo caso una sorta di ballata country ("Goodbye sweetheart"), funge da contrappunto ironico ma toccante: questi ragazzi sono chiamati a servire l'America e a dimenticare tutto della loro vita precedente...
- suggerendo il tono e il genere di un film:
Fight Club (David Fincher, USA/Germania 1999)
I titoli di apertura sono qui sovrapposti a immagini tremolanti (di quelle che potrebbero sembrare connessioni neurali?), con una musica fortemente ritmata in sottofondo. Anche se poi vediamo gli occhi di un ragazzo e una pistola infilata nella sua bocca, non ci viene dato molto in termini di eventi narrativi, ma veniamo invece introdotti al tono del film, che in superficie potremmo qualificare come un thriller: tuttavia, le immagini sfocate sembrano enfatizzare l'ambiguità della narrazione che seguirà, i significati incerti che verranno trasmessi ...
7.2. Le sequenze di chiusura
Le sequenze di chiusura sono l'altro momento cruciale
di un'esperienza di visione, quando le aspettative del pubblico si confrontano
con la risoluzione della trama e portano all'adempimento finale del "contratto"
tra film e pubblico: la "promessa" di un certo tipo di esperienza e la sua
effettiva realizzazione in termini di "chiusura" della storia.
Nel cinema "classico", i finali dei film tendevano a soddisfare le aspettative
stabilite durante tutto il film, con il pubblico che trovava ciò che si
aspettava accadesse fin dall'inizio del film, in particolare in termini di ciò
che un particolare genere cinematografico modellava come aspettative
"legittime". In molti casi, ciò coincideva con il "lieto fine" che gli
spettatori potevano aspettarsi, come il cattivo eliminato dall'eroe in un
western o la riunione finale di una coppia in una commedia o in un dramma.
Tuttavia, l'etichetta "felice" applicata al finale di un film non è priva di
ambiguità. "Felice" potrebbe significare più di una semplice, superficiale
conclusione "positiva" di un film in base alle sue aspettative "generiche", e
potrebbe ben comprendere altri modi più complessi di portare una trama, o l'arco
narrativo di un personaggio, alla sua risoluzione. Anche nel cinema
hollywoodiano "classico", i finali potevano essere strutturati in modo tale che
gli spettatori potessero "goderseli" senza necessariamente implicare una
risoluzione in termini di "felicità" (sia dal punto di vista di un personaggio
che da quello di uno spettatore). Ad esempio, La donna del bandito (Nicholas
Ray, USA 1948) racconta la tragica storia di un ragazzo di 23 anni, Bowie
(Farley Granger), che, durante i tempi difficili della Grande Depressione
nell'America degli anni '30, è stato condannato per un omicidio commesso all'età
di 16 anni. Fugge di prigione insieme a due criminali più anziani, che lo
coinvolgono in una rapina in banca. Mentre si innamora di una ragazza, Bowie
cerca disperatamente di scappare sia dai suoi ex compagni di prigionia che dalla
polizia, ma alla fine viene rintracciato e ucciso davanti alla sua ragazza.
Questo non è un "lieto fine" in termini assoluti, tuttavia le aspettative del
pubblico sono soddisfatte, sia in termini di giudizio morale (Bowie ha
precedenti penali, dopotutto, e in un certo senso merita di essere "punito"),
sia in termini di azione drammatica e "romantica" (la sua tragica storia d'amore
risuona negli spettatori, che possono simpatizzare con la sua situazione e in
questo modo "godersi" il finale non proprio felice (in un modo che è ovviamente
molto diverso dalla conclusione "felice" di, ad esempio, una commedia).
La donna del bandito/They live by night
le sequenze di chiusura possono anche implicare un certo grado di sorpresa, quando la risoluzione della trama va contro le aspettative "naturali" degli spettatori, anche se, come abbiamo già detto, il finale deve comunque preservare un certo grado di coerenza con il contesto della storia così come è impostato durante tutta la narrazione del film. Ad esempio, A qualcuno piace caldo (Billy Wilder, USA 1959) coinvolge il pubblico in due diverse "storie d'amore", una su una coppia eterosessuale standard e tradizionale (Sugar, la cantante e suonatore di ukulele (Marilyn Monroe) e Joe, il sassofonista (Tony Curtis)), e l'altra su una coppia "impossibile" (un milionario anziano e Jerry, il contrabbassista travestito da donna (Jack Lemmon)). Per quest'ultima coppia non esiste una "via d'uscita" realistica, ma il film la conclude abilmente con la famosa battuta finale ("Nessuno è perfetto!"): ancora una volta, non si tratta di un lieto fine "classico" e certamente non di un finale "realistico", ma il pubblico può comunque godersi la sorprendente battuta finale e considerarla una conclusione accettabile, seppur inaspettata.
A qualcuno piace caldo/Some like it hot
Il cinema "moderno" e "postmoderno" racconta spesso storie che coinvolgono personaggi complessi e serie di eventi che portano a finali incerti e "aperti". Uno dei primi esempi tratti dal cinema della "New Hollywood" è Il laureato (Mike Nichols, USA 1967), che racconta la storia di Benjamin (Dustin Hoffman), un ragazzo che viene sedotto da un'amica di famiglia (Anne Bancroft), anche se poi si innamora della figlia di quest'ultima, Elaine (Katharine Ross). Determinata a superare rapidamente lo scandalo, la famiglia di Elaine organizza un matrimonio con un altro ragazzo e Benjamin corre disperatamente verso la chiesa dove Elaine si è appena sposata. Benjamin strappa la ragazza dalle mani dello sposo e scappa con Elaine a bordo di un autobus. Nella sequenza finale, i due siedono sorridenti sul retro dell'autobus, ma le loro espressioni diventano subito incerte: quando Benjamin guarda Elaine, lei distoglie lo sguardo, pensierosa; quando Elaine guarda Benjamin, lui sorride, ma in una direzione diversa. In realtà non si guardano l'un l'altro, ma guardano davanti a sé, come se fossero di fronte al futuro, con insicurezza se non con vera apprensione: chi potrebbe dire che "vissero tutti felici e contenti"? E tutto questo mentre ritorna il motivo musicale ("The sound of silence", di Simon & Garfunkel), che aveva aperto il film e accompagnato i momenti più tristi della storia, e che ora sigilla la situazione finale dei personaggi con un ... "silenzio". Gli spettatori non vedono le loro aspettative realmente sovvertite, ma non possono nemmeno godere di un "lieto fine" completo e conclusivo.
Il laureato/The graduate
Allo stesso modo, alcuni recenti "film giudiziari", ovvero film che coinvolgono un crimine e un processo in tribunale, vanno contro le aspettative più ovvie per questo genere cinematografico, ovvero che gli eventi siano spiegati chiaramente, che venga pronunciata una sentenza e che "giustizia sia fatta". Al contrario, la narrazione dei dettagli del crimine è spesso ambigua, i personaggi non sono descritti in modo chiaro e gli eventi, compresi i flashback, complicano la storia e si evolvono in modi contraddittori. Di conseguenza, agli spettatori non viene offerta una trama lineare e strutturata e alla fine vengono condotti a un finale molto aperto, in cui non c'è una conclusione "ufficiale" e nessuna rivelazione di "colpa" o "innocenza", nessuna scoperta della "verità". Si potrebbe pensare che finali così "insoddisfacenti" possano frustrare il pubblico, ma in realtà il loro interesse e coinvolgimento sono mantenuti alti dall'accumulo di contraddizioni e ambiguità, in modo che possano trovare soddisfazione nell'elaborare i fatti stessi - invece di costruire aspettative verso un risultato definito, tali film invitano gli spettatori a prendere parte attiva all'analisi della trama e dei suoi personaggi e in questo modo ad accettare anche un finale aperto senza sentirsi frustrati. Ancora una volta, il pubblico "apprezza" questi film in modi molto diversi rispetto a quanto potrebbe fare in una trama convenzionale. Ad esempio, in Saint Omer (Alice Diop, Francia 2022), seguiamo il caso di Laurence Coly, una studentessa laureata e immigrata senegalese accusata dell'omicidio della figlia di 15 mesi, abbandonata su una spiaggia e morta per annegamento. Nonostante vengano presentate numerose prove, il film si conclude prima che venga annunciato l'esito del processo, lasciando così che gli spettatori siano lasciati al proprio giudizio. E Il caso Goldman (Cédric Kahn, Francia 2023) racconta del secondo processo a Pierre Goldman, un militante di estrema sinistra accusato di aver ucciso due persone durante una rapina finita male. La difesa fatica a collaborare con questo imputato ribelle, che sembra più interessato a sfruttare il processo come un modo per dichiarare le sue opinioni politiche, ma riesce comunque a individuare evidenti incongruenze nella versione ufficiale dei fatti. Goldman alla fine viene assolto, ma la storia lascia agli spettatori più di un dubbio.
|
Saint Omer |
Il caso Goldman |
8. L'importanza dei generi cinematografici
8.1. Le convenzioni "di genere"
I generi cinematografici sono un’altra prova dello stretto rapporto tra i film e il loro pubblico. Man mano che certi tipi di film diventano popolari, cioè man mano che cresce il loro fascino per ampi settori di pubblico, l'industria cinematografica li riconosce come un "tipo" distinto di film e nascono dei generi, con film di un genere particolare che iniziano ad essere prodotti su larga scala. I generi vengono quindi definiti e riconosciuti come uno degli elementi principali del "contratto" tra produzione e consumo (Nota 5).
Il fattore cruciale che spiega l'importanza dei generi cinematografici ha a che fare proprio con le aspettative del pubblico. Gli spettatori iniziano a guardare un film "di genere" aspettandosi di trovare convenzioni particolari e ben note del genere illustrate dal film. Una convenzione è, ad esempio, il fatto che nei musical, i personaggi spesso passano senza problemi dal parlare al cantare e ballare seguendo una musica che all'improvviso sembra nascere dal nulla: gli spettatori accettano prontamente questo come "parte del gioco" di guardare un musical. Al contrario, questa convenzione non sarebbe accettabile in un film drammatico, "epico" o di guerra, in cui siamo invitati a "sospendere la nostra incredulità" e ad addentrarci nel mondo immaginario del film, che deve garantire un certo grado di realismo per rappresentare un mondo illusorio ma "credibile".
Le convenzioni coprono un'ampia gamma di elementi filmici, ad esempio:
- lo "stile": il film noir, ad esempio, utilizza contesti bui, scene notturne, nonché flashback come strutture narrative formali, mentre il melodramma usa spesso eccessi stilistici per sottolineare i sentimenti e le emozioni dei personaggi: una messa in scena eccessiva, con colori vividi che evidenziano la presenza di numerosi oggetti che diventano parte dell'atmosfera emotiva; uso di luci contrastanti; e un'azione eccessiva che sottolinea le passioni che si celano sotto la superficie delle cose;
- la colonna sonora (rumori e musica): ad esempio, i film horror perderebbero gran parte del loro impatto se rimuovessimo la musica e i suoni che ci tengono con il fiato sospeso, solo per essere interrotti, a volte in modo del tutto inaspettato, da altri suoni che ci fanno sobbalzare; e le "sviolinate" accompagnano spesso storie d'amore e altri tipi di dramma romantico, mentre colonne sonore elettroniche, persino sperimentali, vengono utilizzate per film di fantascienza;
- l'ambientazione: lo spazio e il tempo, cioè dove e quando si svolge la storia di un film, sono particolarmente importanti per alcuni generi, meno per altri. Commedie e drammi, ad esempio, possono svolgersi ovunque e in qualsiasi momento (nel passato, nel presente e nel futuro), ma la maggior parte dei western si concentra sulla frontiera americana (a ovest del Mississippi) nella seconda metà del XIX secolo; i film horror spesso scelgono un luogo isolato (un lago, un cottage in una foresta, un edificio abbandonato, un seminterrato, un cimitero) come cornice perfetta per i brutali omicidi messi in scena;
- l'iconografia: si riferisce al modo in cui persone, oggetti, animali e persino idee astratte vengono utilizzati nei film. Alcune persone e oggetti, per il fatto stesso di essere apparsi in una lunga sequenza di film, sono così diventati icone di quel particolare genere, cioè sono facilmente accettati come simboli nella realtà immaginaria del film: carri, cavalli, diligenze, sceriffi, pistoleri, "indiani" nei western; sacerdoti come "esorcisti" nei film horror; impermeabili, sigarette e pistole come caratteristiche essenziali del detective nei classici film noir; e naturalmente diversi film ben definiti basati su argomenti specifici (come i film sportivi e di guerra) hanno i loro set di icone;
- storie/temi e le loro strutture narrative: la maggior parte dei film si basa su una trama che suggerisce una sorta di conflitto tra i personaggi (a volte anche all'interno di un personaggio) o tra i personaggi e una forza esterna, il che implica un problema che deve essere risolto, solitamente superando gli ostacoli per raggiungere un nuovo "equilibrio" entro la fine del film. Generi diversi presentano conflitti di diverso genere: non solo eroi e cattivi (che si tratti di un western, di un horror o di un film di fantascienza), ma anche amanti e le loro difficoltà (come nelle commedie e nei film drammatici). Tuttavia, come abbiamo già accennato, la "chiusura" finale (compreso, ma non necessariamente, un "lieto fine") non è affatto obbligatoria: anche nei film classici, e sempre più nel cinema postmoderno e contemporaneo, un film può lasciare aperte le sue questioni fondamentali, negando così al pubblico la sensazione rassicurante di un nuovo ordine e di un equilibrio conclusivo. Inoltre, le storie possono gestire i temi sottostanti in modi diversi in diversi contesti socio-culturali;
- i personaggi e le/gli interpreti: i tratti psicologici dei personaggi, e soprattutto i loro obiettivi e motivazioni, spiegano il loro comportamento e i ruoli che svolgono nella trama generale. Nei film di genere tendono ad essere "icone", cioè tipi riconoscibili che simboleggiano i temi principali espressi nel film, e, come tali, corrono il rischio di diventare stereotipi o addirittura caricature: il detective e la "femme fatale" nel film noir, lo zombie o il serial killer nei film horror, gli "amici" e i "nerd" nelle commedie per adolescenti, l'allenatore e i membri della squadra nei film sportivi, la cavalleria e gli "indiani" nei western, e così via.
Nel loro insieme, queste convenzioni aiutano a
modellare le aspettative con cui gli spettatori possono legittimamente reagire,
sia cognitivamente che affettivamente, al particolare film che scelgono di
guardare (ad esempio ridere, piangere, divertirsi, provare suspense,
elaborare pensieri, ecc).
8.2. Fra tradizione innovazione
I generi cinematografici, per loro stessa definizione, implicano che le loro particolari convenzioni siano rispettate e riconosciute dal pubblico, cosicché si formino e alla fine si confermino aspettative appropriate. Tuttavia, come abbiamo detto, i registi non possono limitarsi ad applicare una formula, correndo così il rischio di annoiare gli spettatori. Ciò richiede un equilibrio dinamico tra il "vecchio" (convenzioni consolidate) e il "nuovo" (modi in cui le convenzioni vengono infrante), in modo che gli spettatori possano, da un lato, essere rassicurati sugli elementi fondamentali di un genere e, dall'altro, sfidati e incuriositi da alcuni elementi originali. Confermare o sovvertire le aspettative è una questione di gradi: la Fig. 3 mostra che, da un lato, i generi "classici" assicurano il massimo della conferma mentre, dall'altro, i film "artistici" o sperimentali forniscono un grado (solitamente alto) di sovversione (tuttavia, si noti che il pubblico di un film sperimentale potrebbe essere consapevole sin dall'inizio che la sua esperienza visiva includerà elementi insoliti o inaspettati).
"conferma" "sovversione"
<---------------------------------------------------------------------->
generi "classici" film sperimentali
Fig. 3
8.3. L'ibridazione dei generi
Il fatto che per la loro stessa esistenza i generi cinematografici debbano basarsi su un equilibrio tra ripetizione e variazione li rende oggetti adatti a una miscelazione produttiva. Soprattutto negli ultimi decenni si è verificata la tendenza a mescolare i generi cinematografici in un processo di ibridazione. È abbastanza comune parlare, ad esempio, di commedie romantiche (rom-com), drammi/commedie (dramedies), documentari e finzione (docufiction) e film che mescolano azione e avventura, supereroi e fantasy, detective e mistero, e così via. Questo fenomeno non è nuovo nel cinema mainstream: ad esempio, in I protagonisti (USA 1992), il regista Robert Altman racconta la storia di un produttore (Tim Robbins) che deve esaminare ogni giorno decine di sceneggiature che gli vengono sottoposte e, così facendo, cerca di garantire che in un possibile film da finanziare vengano presi in considerazione quanti più generi possibili. La brillante ironia del film cattura efficacemente i suoi sforzi, ma potremmo aggiungere che il film di Altman è esso stesso un misto di commedia, dramma e thriller, con una chiara visione satirica delle pratiche senza scrupoli di Hollywood.
I protagonisti/The player
Più di recente, Parasite (Bong Joon Ho, Corea del Sud 2019) racconta la storia di una famiglia povera che si infiltra nella vita di una famiglia benestante, prendendo parte a una serie di eventi che spaziano dalla commedia al thriller, con un forte sguardo satirico sulla società coreana odierna. Ed Emila Pérez (Jacques Audiard, Francia 2024) segue il capo di un cartello messicano (Karla Sofía Gascón) che mira a scomparire e trasformarsi in una donna con l'aiuto di un'avvocatessa (Zoe Saldaña): il film mescola in modo efficace e fluido thriller, commedia dark e melodramma, ma è stato anche descritto come un film poliziesco musicale, poiché i suoi personaggi a volte esplodono cantando come nei musical classici (anche se la logica sottesa e i suoi effetti sono molto diversi).
|
Parasite |
Emilia Pérez |
Alcuni casi di mescolanza di generi (o film ibridi)
possono essere compresi anche facendo riferimento a questioni socio-culturali
più ampie. Come abbiamo accennato nella Sezione 5.3, il cambiamento delle
sensibilità culturali e dei modelli socio-culturali si è sempre rispecchiato nel
cinema: gli ultimi decenni hanno assistito a un’impressionante crisi di
ideologie e valori occidentali, lasciando dietro di sé visioni del mondo non più
caratterizzate da chiare opposizioni. La dinamica "buono vs cattivo" di tanti
generi classici (ad esempio sceriffo e cattivo nel western; gangster e polizia
nel film poliziesco; e personaggi "opposti" nei drammi e nelle commedie) è stata
sostituita da un'opposizione più sfumata tra personaggi, che il più delle volte
sono problematici e in un certo senso indefinibili (come il detective
tormentato che ha una serie di problemi personali), riflettendo l'instabilità,
se non il caos, che caratterizza i contesti sociali e culturali moderni. Il
presente è spesso fonte di ansia e dubbio, e il futuro è spesso visto in termini
cupi se non del tutto distopici. Anche gli sviluppi tecnologici vengono, il più
delle volte, descritti come fonte di possibili problemi e sfide poco chiare. Già
Blade Runner (Ridley Scott, USA/Hong Kong 1982), ad esempio, incorporava
molti di questi temi, mettendo in discussione la natura stessa degli esseri
umani e il loro ruolo in una società oscura e futuristica, e lo faceva rendendo
chiari omaggi a vari generi, dalla fantascienza ai romanzi polizieschi, dai film
d'azione ai film noir.
Blade runner
Il fatto che il pubblico moderno accetti questa mescolanza di generi e tolleri un grado piuttosto elevato di sovversione delle convenzioni di genere dimostra, ancora una volta, che, man mano che gli spettatori diventano più informati sui film e sulla produzione cinematografica, l'industria cinematografica può "correre più rischi" e "estendere" i confini dei generi oltre livelli che un tempo sarebbero stati inimmaginabili (e inaccettabili). Tale flessibilità sia da parte dei produttori che dei consumatori può arrivare addirittura, paradossalmente, a produrre delusione quando non vengono violate le aspettative, il che, almeno per alcuni membri del pubblico, può significare nessuna trasgressione delle convenzioni e quindi minori opportunità di stimolare la riflessione e un minor grado di interesse e partecipazione. Al contrario, non bisogna dimenticare che sovvertire le aspettative di genere può spesso essere ancora un processo pericoloso: alcuni tipi di pubblico possono scoraggiarsi a causa di un'eccessiva "sovversione" del genere, sentirsi "persi" e alla fine perdere interesse.
8.4. L'"appropriazione" di argomenti e temi
Invece di mescolare generi all'interno di un singolo film, a volte i film possono incorporare elementi distinti di un genere particolare, rendendoli parte della narrazione principale. Ciò può essere spiegato facendo riferimento al concetto di intertestualità, ovvero al riferimento, all'interno di un'opera, ad altre opere, il che ovviamente implica che gli spettatori abbiano familiarità con i contenuti "più vecchi" - un altro modo per il pubblico di sfruttare le proprie conoscenze ed esperienze pregresse di opere precedenti per apprezzare e godere di quelle nuove. Questo è ciò che accade in Frankenstein Junior (1974 - si veda la Sezione 8.5), che imita scene del film originale di Frankenstein, La moglie di Frankenstein (James Whale, USA 1935). Come esempio particolarmente illuminante, consideriamo Dalle 9 alle 5 - Orario continuato (Colin Higgins, USA 1980), che racconta la storia di tre segretarie(interpretate da Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton) che vivono le loro fantasie di vendicarsi del loro capo "sessista, egoista, bugiardo, ipocrita bigotto" (Dabney Coleman). Nella fantasia, Violet (Lily Tomlin), si immagina vestita da Biancaneve, in compagnia di animali animati della foresta, mentre dà da mangiare al suo capo una mela velenosa - un chiaro riferimento parodico al classico Disney. Ciò presuppone chiaramente che sia Violet sia il pubblico conoscano appieno il genere dei cartoni animati.
Dalle 9 alle 5 - Orario continuato/9 to 5
8.5. Le parodie
"Lo sviluppo dei generi ... culmina in una forma (la parodia) che si basa sulla piena comprensione, da parte del pubblico, degli elementi e dei temi del genere in questione. Si tratta dell'adempimento del “contratto” tra creatori di contenuti e spettatori, in base al quale il rapporto a lungo termine degli spettatori con il genere ha consentito loro di comprendere e apprezzare una parodia. Il pubblico “capisce” la battuta ... grazie alla quale solo coloro che sono esperti (vale a dire con una conoscenza approfondita del genere) vengono pienamente ricompensati." (Nota 6)
Lo sviluppo naturale dei generi porta a film che,
facendo riferimento a uno o più generi specifici, diventano autoreferenziali (e
quindi raggiungono una sorta di riflessività) e, come cambiamento più radicale,
diventano parodie di un genere cinematografico - in un certo senso il
riconoscimento ultimo che un genere ha pienamente sviluppato il suo potenziale
intrinseco e può ora essere sfruttato a livello secondario, esponendone e
satireggiandone le forme e le convenzioni. Nelle parodie, le convenzioni di un
genere vengono riciclate con uno scopo comico. Ciò presuppone che il pubblico
conosca appieno le caratteristiche principali di un dato genere, in modo che gli
spettatori possano riconoscerle, il che, a sua volta, offre agli stessi
spettatori un doppio motivo di intrattenimento, poiché possono apprezzare le
convenzioni originali del genere parodiato e, allo stesso tempo, apprezzare il
modo comico o satirico con cui tali convenzioni vengono trattate. Praticamente
ogni genere ha dato origine a corrispondenti parodie, che a volte hanno avuto
molto successo come film "originali" a pieno titolo. Tra gli esempi rientrano
l'horror, il western e i cosiddetti "film catastrofici", diventati popolari
negli anni '70.
 Frankenstein Junior/Young Frankenstein (Mel Brooks, USA 1974) |
|
 Blazing saddles (by Mel Brooks, USA 1974) |
 Airplane! (by Zucker-Abrahams-Zucker, USA 1980) |
8.6. Le aspettative di genere attraverso le culture
Un'ultima caratteristica importante dei generi merita
di essere sottolineata: sebbene si possano attribuire termini molto generici
come "commedia" o "melodramma" a una varietà di film prodotti in momenti diversi
della storia, in contesti nazionali diversi e da autori diversi, questa natura
"universale" dei generi è in realtà il prodotto di una visione piuttosto
etnocentrica. La maggior parte degli studi sui generi cinematografici ha preso
come obiettivo principale il cinema occidentale, e Hollywood in particolare,
spesso ignorando o minimizzando l'importanza di altri cinema nazionali, molti
dei quali hanno sviluppato propri "generi", spesso difficili da comprendere e
apprezzare da occhi occidentali. Alcuni generi nazionali hanno le loro
caratteristiche distintive, ma spesso rimangono isolati all'interno dei loro
confini, poiché non godono di una distribuzione mondiale. Inoltre, anche se
utilizziamo termini piuttosto generici come "avventura" o "thriller", il loro
significato può cambiare se applicato a diversi cinema nazionali o locali - ad
esempio i film indiani di "Bollywood" o quelli asiatici di arti marziali - e le
corrispondenti aspettative del loro pubblico saranno diverse.
Note
1. Knight D. 1997. Creating short fiction: The classic guide to writing short fiction, St. Martin's Griffin, New York, p. 54. Citato in Austin A.C. 2007. Expectations across entertainment media, Master thesis, Massachusetts Institute of Technology, pp. 5-6.
2. Ibid., pp. 11-12.
3. Bordwell D. 1985. Narration in the fiction film, University of Wisconsin Press, Madison. Citato in Austin, op. cit., pp. 49-50.
4. Bordwell, op. cit., p. 38. Citato in Bateman J.A. & Tseng C. 2013. "The establishment of interpretative expectations in film", Review of cognitive linguistics, 11, 2, p. 354.
5. Tuttavia, i generi possono anche essere descritti in termini almeno in parte diversi da differenti categorie, ad esempio i critici cinematografici o accademici rispetto ai pubblici. Si veda ad esempio Jeffres L.W, Atkin D.J & Neuendorf K.A. 2023. Audience genre expectations in the age of digital media. Routledge, New York and London, pp. 47-55.
6. Jeffres et al., op. cit, p. 170.
Appendice
Le due schede in questa Appendice forniscono opportunità di sperimentare le aspettative del pubblico con un'analisi di film e dei fattori coinvolti nella personale interazione con essi.
Scheda 1: Alla scoperta delle aspettative
Al cinema, il film è lo stesso. Sei tu che sei diverso.
(Questa frase compare all'uscita del Museo Interattivo del Cinema di Milano.)
Quando ci accingiamo a vedere un film, attiviamo, più o meno inconsapevolmente, diverse aspettative, sulla base delle nostre conoscenze, esperienze, convinzioni e atteggiamenti. Queste aspettative, e le reazioni che innescano durante e dopo la visione, sono largamente responsabili dell'opinione che ci facciamo del film, dell'interpretazione che ne diamo, del giudizio che possiamo esprimere sul film stesso. Le aspettative sono un fattore al contempo condiviso e strettamente personale:
- condiviso, perchè molte altre persone che fanno parte della nostra stessa cultura, o età, o condizione sociale, o professione, o che comunque condividono con noi aspetti importanti della nostra vita, possono tendenzialmente avere un bagaglio di conoscenze ed esperienze simile al nostro; ma nello stesso tempo
- personale, perchè, come esseri umani unici e irripetibili, ognuno di noi è portatore di differenze individuali e di esperienze non sovrapponibili a quelle di nessun altro.
Proviamo a vedere come funzionano questi meccanismi nel concreto. Pensa ad un film che vorresti vedere prossimamente. Nella Scheda che segue, compila, per quanto ti è possibile, la colonna Fattori da considerare. Poi, in base a questi dati, scrivi nella colonna accanto le Aspettative che vengono generate nella tua mente. Ad esempio, se stai per andare a vedere l'ultima commedia di Woody Allen, potrai scrivere nella colonna Aspettative qualcosa come ... uno o pìù personaggi in "crisi esistenziale", oppure una serie di battute a raffica, o ancora un'ambientazione in una città famosa o ... Per fare un altro esempio, se i tuoi amici ti hanno raccomandato un film e ti hanno detto di cosa parla, potrai riassumere brevemente quello di cui sei già venuto a conoscenza. O ancora, se stai per andare a vedere un film "horror", potrai citare alcuni elementi che ti aspetti di ritrovare: un gruppo di amici progressivamente eliminati da un omicida, scene di tortura, abbondante spargimento di sangue ("splatter"), e così via.
Una volta completata la scheda, e dopo aver visto il film in questione, potrai confrontare le tue aspettative con le tue effettive reazioni, prendendo qualche appunto, se vuoi, nell'ultima colonna. Sarai così in grado di giudicare in che misura il film ha corrisposto alle tue aspettative o le ha invece contraddette.
| Fattori da considerare |
Aspettative | Le mie reazioni | |
|
Film - titolo - anno e paese di produzione - durata - fa parte di una serie o di una "saga" che già conosci? - ha vinto un premio in qualche festival? - se ne è parlato (sui giornali, in televisione, su Internet ...) per qualche motivo particolare? - c'è stata una campagna pubblicitaria? - se si tratta di un film che vedrai al cinema, è un film che si suppone sarà molto popolare e ben distribuito nelle sale oppure che sarà visibile solo in poche sale e/o per pochi giorni? - altro: ................................................. |
|||
| Regista - hai già visto altri suoi film? Gira un certo tipo particolare di film? - quali temi tratta di solito? - sai qualcos'altro di lei/lui? - altro: ................................................. |
|||
| Attori/Attrici - sono famosi? Per quali altri film che ti vengono in mente? - interpretano di solito ruoli più o meno simili? Se sì, quali? - c'è qualcosa di particolare che apprezzi o non apprezzi in loro? - altro: ................................................. |
|||
| Genere - il film appartiene chiaramente ad un certo "genere"? Oppure è difficile da "incasellare"? - è un genere (o sotto-genere) di cui sei appassionato? - quali aspetti di questo genere di solito ti interessano o ti coinvolgono di più? - altro: ................................................. |
|||
| Trama o argomento - sai già qualcosa sulla trama del film? - parla di argomenti che già conosci o che ti sono in qualche modo familiari? - è ambientato in ambienti e in una "cultura" che ti è più o meno familiare o di cui conosci poco o niente? - altro: ................................................. |
|||
| Critica e giudizi - hai letto qualche recensione, critica, o comunque informazioni sul film? - ne hai parlato con amici, parenti, conoscenti? - "girano" voci, ad esempio sui social networks, sul film, sul regista, sugli attori, sulla trama, ecc.? - ti è stato raccomandato da qualcuno? Perchè? - lo hai scelto tu o hai accettato la decisione di altri? - altro: ................................................. |
|||
Scheda 2: Aspettative alla prova
Ognuno di noi arriva a vedere un film con tutta una serie di aspettative, che riguardano moltissimi fattori: dal genere di film agli attori, dalle recensioni che abbiamo letto alle nostre precedenti conoscenze dell'argomento trattato ... e così via. Spesso queste nostre aspettative ci vengono confermate dalla visione del film; altre volte, invece, vengono smentite in modo più o meno sostanziale. Ovviamente, il piacere della visione di un nuovo film non si può basare sull'aspettativa di vedere soltanto qualcosa che ben conosciamo - ma è vero anche che in un certo tipo di film, quel "tipo" o "genere" che ci sta a cuore, ci fa piacere ritrovare certi attori, certe situazioni, certi sviluppi del racconto che ci sono familiari e non pretendiamo (o non tolleriamo) grossi stravolgimenti. La produzione cinematografica ha ben chiari questi processi ed è attenta a fornire "prodotti" che siano per quanto possibile nuovi ed originali, ma anche altri prodotti più "rassicuranti", che si basano sulla "fidelizzazione" di un pubblico affezionato (tra l'altro, si spiega così la longevità di "saghe" o "serie" come quelle di James Bond o di Star Wars, e l'enorme diffusione delle serie televisive "pluri-stagionali" ...).
Questa attività ti permetterà di verificare quanto le tue aspettative siano poi effettivamente confermate dalla visione di un film oppure siano parzialmente smentite, o ancora decisamente stravolte. Nella Scheda che segue, troverai una sintesi delle prime sequenze di alcuni film. Scrivi accanto a ciascuna sintesi che cosa ti aspetti che succeda nel film, come credi si possa sviluppare la vicenda presentata e come possa concludersi. Per una riflessione più articolata, se vuoi, scrivi anche nella terza colonna sulla base di quali criteri sei giunto a crearti le tue aspettative (il titolo del film? Il genere a cui appartiene? Il regista? Gli attori/attrici? ecc.). Poi confronta quanto le tue aspettative vengono confermate o smentite nella successva Scheda di controllo, che ti fornirà una breve sintesi della trama complessiva di ogni film.
N.B. Ovviamente questo lavoro funziona meglio con film che non hai mai visto o di cui hai solo un vago ricordo. Se conosci bene il film, potresti comunque cercare di descrivere quali aspettative si creerebbe un nuovo spettatore.
| Breve sintesi delle
sequenze iniziali |
Aspettative | Criteri |
|
Paura in palcoscenico
(Stage fright),
di Alfred Hitchcock, USA 1950, con Marlene Dietrich, Jane Wyman, Richard
Todd, Michael Wilding Jane, una giovane studentessa (Wyman) aiuta l'amico Jonathan (Todd) a scappare dalla polizia che lo insegue. Jonathan le racconta in un flashback che la sua amante Charlotte (Dietrich), una diva del music-hall, ha ucciso in una lite il marito, e si è poi presentata a casa sua sconvolta e col vestito macchiato di sangue. Jonathan ha cercato di aiutarla, andando persino a casa di Charlotte per prenderle un vestito pulito, ma forse è stato visto dalla cameriera di Charlotte ed ora è nei guai ... |
||
|
Maurice
(Maurice), di James
Ivory, GB 1987, con James Wilby e Hugh Grant A Cambridge negli anni '10 del Novecento, due studenti, Maurice e Clive (Wilby e Grant) si innamorano - ma il clima è fortemente repressivo e l'omosessualità un reato. L'amore dei due è ancora platonico quando il termine degli studi si avvicina ... |
||
|
L'asso nella manica
(Ace in the hole), di Billy
Wilder, USA 1951, con Kirk Douglas, Jan Sterling In una miniera del Nuovo Messico un minatore (Sterling) rimane sepolto vivo. Accorrono giornalisti, radio e televisioni per seguire "in diretta" il caso. Un giornalista (Douglas) si mette in contatto con la moglie del minatore e ne conquista la fiducia ... |
||
|
Arlington Road - L'inganno
(Arlington Road), di
Mark Pellington, USA 1999, con Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack Michael Faraday (Bridges), vedovo da tre anni, abita con il figlio di 10 anni in una villetta alla periferia di Washington. Un giorno soccorre il bambino dei suoi nuovi vicini di casa Lang (Robbins e Cusack), rimasto ferito durante l'esplosione di fuochi d'artificio. Questo avvicina Michael ai Lang, che si dimostrano aperti e cordiali. Tuttavia, Michael comincia a sentirsi a disagio quando scopre qualche piccola bugia di Lang e degli strani disegni in casa sua ... |
||
|
Ricky - Una storia d'amore e libertà
(Ricky),
di François Ozon, F/I 2009, con Alexandra Lamy, Sergi Lòpez L'operaia Katie (Lamy), che vive sola con la figlia adolescente, si innamora di un nuovo assunto, Paco (Lòpez) nella ditta dove lavora e resta incinta. La presenza del nuovo arrivato, il piccolo Ricky, rende più difficile la convivenza, anche perchè il bambino si dimostra piuttosto "difficile". Ad un certo punto, quando gli compaiono sulla schiena strani lividi, Katie comincia a sospettare del comportamento di Paco ... |
||
|
Ascensore per il patibolo
(Ascenseur pour l'échafaud), di
Louis Malle, F 1958, con Jeanne Moreau, Maurice Ronet Un venerdi sera Julien (Ronet) uccide il direttore del suo ufficio, con l'intento di avere via libera con la moglie Florence (Moreau), sua amante. Ma durante la fuga, nell'intento di recuperare una corda che potrebbe accusarlo, Julien rimane bloccato nell'ascensore che il custode ferma per il weekend. Florence vaga a lungo per Parigi, con la cocente delusione che Julien l'abbia abbandonata. Nel frattempo, una coppia di giovani ladruncoli ruba l'auto di Julien ... |
Scheda di controllo
|
Paura in palcoscenico Jane, oltre a nascondere Jonathan, intraprende delle ricerche, conoscendo in tal modo (e innamorandosene) l'Ispettore Wilding. Dopo una serie di peripezie, in un drammatico confronto nel teatro dove Charlotte lavora, si scopre che Jonathan è il vero assassino, e Jane riesce a salvarsi per miracolo da lui. Il film, uno dei meno conosciuti di Hitchcock, è famoso proprio per il flashback iniziale che è finto - in altre parole, Hitchcock, in questo caso più unico che raro, ha deliberatamente imbrogliato il pubblico - creando una serie di false aspettative! Recensione su filmtv.it
Maurice Le strade dei due amici divergono: mentre Maurice comincia a lavorare nella City di Londra, Clive parte per un viaggio in Grecia, anche per cercare di staccarsi dalla sofferenza di questo amore "impossibile". Maurice, dopo aver tentato di "curare la sua malattia", accetterà la sua omosessualità, unendosi allo stalliere di Clive e affrontando le inevitabili difficoltà che lo aspettano. Clive invece finirà per sposare una ragazza della sua stessa classe sociale e cercherà di condurre una vita "normale" ... Recensione su filmtv.it
L'asso nella manica In realtà il giornalista, ambizioso e arrivista, facendo finta di fare il possibile e arrivando a coordinare le squadre di emergenza, cercherà in tutti i modi di rimandare i tentativi di salvataggio per poter sfruttare fino in fondo il suo "scoop". Rimarrà in contatto con il minatore fino alla morte di quest'ultimo ... Recensione su mymovies.it
Arlington Road - L'inganno I sospetti di Michael si fanno sempre più pressanti: i vicini di casa potrebbero essere dei terroristi che stanno preparando un attentato ... o è solo una sua paranoia? Michael in realtà ha visto giusto: in un crescendo di azione, Lang finirà addirittura per rapire il figlio di Michael il giorno in cui l'attentato viene messo a segno. Ironia della sorte, Michael rimarrà ucciso nell'attentato e sarà accusato di esserne il responsabile. Suo figlio verrà affidato a dei parenti, mentre i coniugi Lang continueranno la loro tranquilla vita borghese ... Recensione su mymovies.it
Ricky - Una storia d'amore e libertà Accusato di maltrattare il bambino, Paco se ne va di casa. Ma i segni sulla schiena del piccolo continuano ad ingrandirsi, e Katie non sa più che fare. Un giorno, mentre sono in un parco, questi lividi si trasformano in ... piccole ali, e Ricky comincia a librarsi in aria. Katie, sorpresa e all'inizio sconvolta, lascerà che Ricky prenda il volo verso la sua libertà ... Recensione su filmtv.it e su mymovies.it
Ascensore per il patibolo Mentre Julien tenta inutilmente di uscire dall'ascensore, la coppia di ladruncoli si ferma in un motel e conosce una coppia di turisti tedeschi, con i quali scattano delle foto, usando la macchina fotografica di Julien. Queste foto vengono lasciate al motel per lo sviluppo ... Durante la notte, nel tentativo di rubare loro l'auto, i due giovani uccidono i turisti con la pistola trovata nell'auto di Julien. La mattina successiva la polizia ferma per vagabondaggio Florence e nel frattempo, sulla base dei chiari indizi (l'auto, la pistola) accusa Julien dell'omicidio dei due turisti. Florence, pur negando di conoscere Julien, tenta di scagionarlo.Visto che il marito di Florence è introvabile, la polizia fa aprire l'ufficio e riattiva l'ascensore, liberando così Julien. Florence riesce a ritrovare i due giovani ladruncoli e li accusa dell'omicidio, il che scagionerebbe Julien. A questo punto il ragazzo, ricordandosi che nel rullino lasciato al motel sono presenti foto che ritraggono lui e la sua ragazza con i due tedeschi, si precipita al motel. Qui la polizia sta facendo sviluppare le foto ed è subito chiaro che l'assassinio dei tedeschi è opera dei due giovani. Arriva al motel anche Florence ... solo per scoprire che nel rullino in corso di sviluppo ci sono anche delle foto che Julien aveva scattato con lei, in atteggiamenti intimi ... Recensione su mymovies.it
|